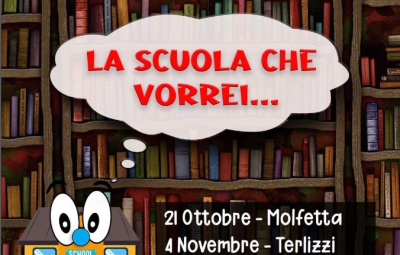Testimoni di tutte le cose da lui compiute
Carissimi,
per il tempo che stiamo vivendo, non poteva essere scelto un versetto della Scrittura più suggestivo, attuale e ispirante di questo: Siamo «Testimoni di tutte le cose da lui compiute» (At 10, 39).
Ogni cristiano è chiamato a essere missionario e testimone di Cristo! E la Chiesa non ha altra missione se non quella di evangelizzare il mondo, rendendo testimonianza a Cristo.
L’identità della Chiesa è evangelizzare! E quindi, l’identità stessa dell’Ac è evangelizzare!
La forma plurale, poi, sottolinea il carattere comunitario-ecclesiale della chiamata missionaria dei discepoli, carattere che Paolo VI già richiamava nel 1975 nell’ Evangelii nuntiandi, quando scriveva: «Evangelizzare non è mai per nessuno un atto individuale e isolato, ma profondamente ecclesiale» (n. 60).
E non vi sembri superflua, infine, anche questa precisazione, implicitamente contenuta nel versetto che stiamo commentando: come discepoli, siamo inviati da Gesù non solo per fare la missione, ma anche e soprattutto per vivere la missione; non solo per dare testimonianza, ma anche e soprattutto per essere testimoni di Cristo; «portando sempre e dovunque nel nostro corpo la morte di Gesù, perché anche la vita di Gesù si manifesti nel nostro corpo» (2 Cor 4,10).
L’essenza della missione è il testimoniare Cristo, vale a dire la sua vita, passione, morte, e risurrezione! Nella Scrittura il testimone è il “martire”, colui che dà la vita per Cristo, ricambiando il dono che Lui ci ha fatto di Sé stesso. È colui al quale è successo qualcosa di particolarmente significativo, e vive segnato da quell’evento. È colui, insomma, che sa e ha visto delle cose che non può non dire.
Testimone non è – come a volte spesso accade nelle nostre pratiche ecclesiali più “ruspanti” – colui che dice ciò che ha fatto, quanto, piuttosto, colui che, attraverso la sua vita, suscita domande nell’altro, a cominciare da quello che lui sente, dice e soprattutto è. Tutto questo lo esprime molto bene San Pietro nella sua Prima Lettera, quando raccomanda: «Siate sempre pronti a rispondere a chiunque vi domandi ragione della speranza che è in voi» (3,15). Sono gli altri a chiedere una risposta! Il testimone è colui che rimane fedele al suo mandato e cerca di essere sé stesso. Per questo, Paolo VI profeticamente diceva: «L’uomo contemporaneo ascolta più volentieri i testimoni che i maestri, o se ascolta i maestri lo fa perché sono dei testimoni» (Evangelii nuntiandi, 41).
Entrerei ora nel cuore della meditazione.
Ho pensato di presentare il grande tema della testimonianza cristiana così come Luca ce lo declina in questo suo secondo libro. Tutto, negli Atti, comincia con l’evento della Ascensione – evento che inaugura il tempo dell’assenza fisica di Gesù – e quindi con l’invito del Risorto alla testimonianza: «Sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria e fino ai confini della terra» (At 1,8).
Ebbene, proprio questo versetto – a detta degli esperti – sarebbe il programma dell’intero libro.
Quello degli Atti, purtroppo, è uno dei libri più trascurati del N.T. ed è un peccato: per come Luca ne imbastisce la trama e ne stende i vari racconti, ci aiuta a interrogarci proprio sulle questioni cruciali che oggi siamo chiamati ad affrontare come Comunità ecclesiale e come Associazione: «Quale Chiesa e quale AC, oggi? Quale messaggio? Come ritrovare e rinvigorire lo slancio evangelico della Chiesa?». O, molto più banalmente: «Da dove possiamo ricominciare?». Perché di ricominciamento si tratta, se vogliamo guardare con libertà e responsabilità il momento che ci è chiesto di vivere.
Il libro, letto superficialmente, può sembrare solo un volume di storia, a tratti anche noioso, con racconti e passaggi dal tono favolistico che ci spiazzano e un po’ ci imbarazzano. Ma una lettura più attenta e paziente ci consegna, invece, tutta la sua ricchezza e il suo carattere programmatico e profetico.
Di fatto, ci aiuta a riflettere sui due momenti essenziali della vita di ogni Comunità:
1°. Individuare l’essenziale! In quanto racconto di inizi, esso ha una valenza identitaria, e il suo scopo è quello di aiutare i destinatari a fondarsi in un’identità, in una memoria. Quando pensiamo alla crisi che la Chiesa e il mondo stanno attraversando, la nostra mente corre subito alle crisi numeriche, strutturali, organizzative, dimenticando che queste sono sempre il riflesso di una crisi più profonda che è di identità.
2°. Trovare il modo e le forme dell’annuncio oggi. Capire, cioè, come portare l’evangelo al mondo.
Questi sono i due momenti che, insieme, fanno la Chiesa. Insieme, mai uno senza l’altro!
Noi spesso rischiamo di trascurare ora uno ora l’altro. O ripieghiamo in una sorta di intimismo identitario che non porta da nessuna parte: accade spesso, infatti, che ci chiudiamo nei ghetti protetti delle nostre abitudini e dei nostri spazi ecclesiali ed associativi che finiscono poi di diventare desolanti e ammuffiti.
O – rischio opposto –, puntiamo tutto sull’estroversione, come se tutto si risolvesse con iniziative eclatanti, spesso discutibili, perché mancano di una consapevolezza di fede adeguata.
Comincerei subito proprio dal secondo movimento, quello che costituisce la grande sfida per la Chiesa di oggi e di sempre: la crescita ad extra, crescita che nel linguaggio del libro è, appunto, la testimonianza, termine che Luca preferisce a quello pure importante di annuncio.
La Chiesa che nasce dalla Pasqua è una Chiesa «estroversa», non rinchiusa nella paura, nei risentimenti, nelle sconfitte, ma sempre con gli occhi aperti sul mondo in cui è chiamata ad essere sé stessa.
Per Luca, solo una Comunità che cresce al suo interno sarà capace di uscire in maniera efficace; solo una Chiesa capace di estroversione resta viva al suo interno. Altrimenti diventa una setta… pericolosa.
I due movimenti sono concomitanti: non accade che prima si cresce all’interno e poi si esce. E questo per il semplice fatto che la Chiesa cresce anche grazie a ciò che proviene da fuori.
Luca, infatti, negli Atti ci parla di un’identità ecclesiale in progress. È un errore madornale pensare che gli Atti ci consegnino un’immagine di Chiesa completa, chiusa! Scorrendo il libro si comprende che la Chiesa realizza la sua identità proprio attraverso quegli incontri che realizza nelle varie situazioni.
Esempio eclatante è proprio l’episodio da cui è tratto il nostro versetto, quello di Cornelio!
Là, infatti, non si capisce chi evangelizza chi? Certo, è Pietro che evangelizza Cornelio, ma è anche Cornelio che evangelizza Pietro, al punto che Pietro dice: «Adesso capisco!». Vedete: anche la vocazione/missione di Pietro si definisce nell’incontro. E questo vale anche per la Chiesa, vale anche per noi, Azione Cattolica. La Chiesa riceve la propria identità nella storia, non al di fuori di essa! E la storia, a sua volta, non è solo quella che riceve l’annuncio, ma è anche quella che aiuta a plasmarlo. Gli apostoli comprendono la loro missione mentre annunciano. Il cammino non è mai chiuso!
- Testimonianza come forza di una vita vissuta
Che cosa attira alla fede, che cosa consente a una Comunità di ingrandirsi, di accogliere nuovi fratelli; che cosa costituisce il primo tratto della testimonianza? La risposta è semplice: la qualità della sua vita!
I primi cristiani che si aggiungono alla Comunità non si aggiungono perché cercati (quando pensiamo alla missione pensiamo a una “uscita” per cercare altri; un’uscita per propagandare. Non è così! All’origine della fecondità di una Comunità, ci ricordano gli Atti, non c’è niente di strategico. La strategia verrà dopo. Il primo messaggio attrattivo è la vita! Se la Comunità vive di quello che la nutre, sarà anche capace di attirare altri: «godevano del favore – in greco charis, potenza di fecondità – di tutto il popolo» (4,33).
Sono fecondi perché vivono in qualcosa! La prima forma di uscita è per così dire statica, non ha niente di mobile. È l’essere, il vivere, la capacità di senso, di bene, di gioia che la Comunità sa trasmettere senza volerlo. È la testimonianza inconsapevole, quella cioè che nasce da una vita vissuta. L’annuncio non è mai pubblicità, e il testimone non è uno che vende un prodotto.
- La testimonianza accade nell’imprevisto del quotidiano
L’«uscita» vera e propria, quella che nella mente di Luca è frutto di una precisa strategia, negli Atti inizia solo al capitolo 8 e inizia in modo tragico, con la dispersione provocata dalle persecuzioni (8,1). Ma questa dispersione, con relativo irraggiamento del Vangelo, ha un’anticipazione in una scena che possiamo considerare una prima forma di testimonianza che merita di non essere trascurata, e cioè quella dell’incontro tra Pietro e Giovanni con il paralitico, mentre vanno al Tempio dalla Porta Bella.
Pietro e Giovanni si fermano, ascoltano, lo prendono per mano e lo sollevano (v. 7). Si tratta di una scena semplice, un gesto di cura che si fa annuncio.
Rileggete il racconto: i due apostoli non erano in missione; scoprono di esserlo perché qualcuno li interpella. Si accorgono di esserlo perché qualcuno chiede la loro cura. La loro è una missione di cura.
Ecco una manifestazione di fecondità, quella che si potrebbe definire la testimonianza nel quotidiano degli incontri casuali, feriali. Spesso pensiamo che la missione si faccia nei grandi momenti, per i grandi raduni.
La prima dimensione di una testimonianza è quella che riguarda tutti. È la testimonianza di chi sa fermarsi a guardare un volto, a tendere una mano, a dire una parola. Non c’è solo l’annuncio alle folle! Non è forse vero che il Gesù dei Vangeli è l’uomo degli incontri prima che dei discorsi?
Un’ultima osservazione su questo secondo punto: noi qui troviamo esplicitato l’unico movente valido per ogni annuncio/testimonianza cristiani. Giustificandosi davanti al Sinedrio che lo accusava per non aver ascoltato il comando di non predicare più, Pietro, con la parresia che lo contraddistingueva, risponde: «Noi non possiamo tacere quello che abbiamo visto e ascoltato».
In queste parole di Pietro, Luca ci dà il fondamento e la ragione di ogni uscita, di ogni testimonianza, di ogni annuncio. La testimonianza nasce da questa esigenza interiore ed irrinunciabile: il non poter tacere ciò di cui abbiamo fatto esperienza. Questa è la radice di ogni missione: non quella di salvare le anime – che ha già salvato Gesù Cristo! – ma di rendere visibile la salvezza di cui siamo partecipi e di rendere coscienti gli altri di essere destinatari di una salvezza che noi sentiamo benefica nelle nostre esistenze.
- La testimonianza si invera nell’incontro con l’escluso.
Vi rimando ora al famoso episodio dell’eunuco (8,26-40). Un capolavoro non solo teologico, ma anche letterario! Questa uscita – a differenza di quella che abbiamo appena visto – non è del tutto casuale (anche se non siamo ancora alle missioni organizzate). Luca sottolinea, però, che questo incontro avviene in obbedienza al piano di Dio. Filippo è mandato a Gaza da un angelo (8,26), e poco oltre si precisa che è lo Spirito a suggerire a Filippo di accostarsi al carro dell’eunuco.
Per comprendere il significato della scena, occorre ricordare chi è questo interlocutore di Filippo, sulla cui identità Luca significativamente si dilunga. L’evangelista qui è così prodigo di particolari, perché sono proprio questi a delineare la complessità della figura. Innanzitutto, è un personaggio eminente: non si tratta dell’ultimo sprovveduto, e tuttavia è un eunuco, e in quanto tale (cfr. Dt 23,2) non gode dei pieni diritti per partecipare al culto. È un marginale, ma ricco. Quanti uomini e donne oggi appartengono a questa categoria, soprattutto nelle nostre società! Si tratta di un uomo ferito, perché escluso. L’apostolo si fa prossimo a quella situazione di solitudine, ascolta quello che l’eunuco legge, e inizia un dialogo intessuto di domande sulla Scrittura. L’annuncio, dunque, viene come risposta: prendendo la Parola, Filippo gli annunciò Gesù (v. 35). L’essenziale, dunque, è lì, in un volto, quello di Cristo! Ma poi, camminano ancora: il processo non è finito. Proseguono lungo la via (v.36) e mentre camminano ecco un’altra domanda, ancora più impegnativa dell’altra: «Cosa impedisce che io sia battezzato?». La domanda non è scontata o banale in bocca all’eunuco, perché per l’eunuco quella è una domanda drammatica. Quante volte a quella domanda si sarà sentito rispondere: «Per la condizione in cui sei!». Lui era un escluso dal Tempio, portava inscritta nella sua storia e nella sua carne il motivo del suo impedimento («Che cosa impedisce?», chiede smarrito). Quell’eunuco che si è sentito dire tante volte «no», ora osa di nuovo la domanda.
Ecco la provocazione che Luca lancia: fino a che punto si può spingere l’annuncio del vangelo?
In questa nuova fase del racconto la domanda è: ci sono situazioni che non consentono l’annuncio?
Filippo – scrive Luca – scese dal carro e insieme all’eunuco si immerge nell’acqua. Ognuno di noi qui può leggere le tante situazioni che viviamo continuamente, in cui ci è chiesto un discernimento che interpella la fede come membri della Comunità credente, come aderenti ad una realtà ecclesiale. E non come singoli.
- La testimonianza verso la diversità culturale
L’episodio che vi propongo ora è quello noto dell’incontro di Paolo con i filosofi di Atene.
Paolo arriva ad Atene (non ha previsto di andarci!) e Atene è la capitale della cultura e della filosofia.
Ebbene, Paolo ha l’impressione di essere caduto su un altro pianeta. Capisce subito che non sta più confrontandosi con una città di provincia. Là sperimenta l’alterità di un mondo con il quale gli era difficilissimo vedere un nesso con la sua fede. Un contesto al quale si sente radicalmente estraneo. Inoltre, si tratta di un mondo esigente: ha a che fare con gli intellettuali. E quelli, la sanno lunga!
La prima reazione di Paolo è quella del disprezzo. Ma il disprezzo, lo sappiamo, è una comoda forma di difesa (quello che non sappiamo affrontare lo disprezziamo: «Sono una massa di dannati!», diciamo).
Ma subito dopo, egli decide di affrontare la città a partire dal suo cuore pulsante che è l’agorà, dove discute con coloro che incontra (v.17). I suoi interlocutori sono i filosofi epicurei e stoici (scuole venerabili) i quali cominciano, spocchiosi, a farsi un’idea di Paolo: «Che vorrà mai questo ciarlatano…».
A questo punto emerge il genio di Paolo, il quale prova ad entrare in dialogo con questi intellettuali, offrendoci uno dei discorsi più belli e coraggiosi, anche se, in un primo tempo, più fallimentari, perché alla fine solo pochi recepiranno l’annuncio. Questo esempio ha tante cose da insegnare a noi oggi.
Fermiamoci solo su due elementi.
Il primo: Paolo valorizza la religiosità dei suoi interlocutori (v.3) attingendo a qualcosa che gli consente un aggancio con il Dio cristiano (comincia richiamando l’iscrizione che trova sull’ara: «Al dio ignoto»).
Parte da quella realtà, cerca cioè di trovare un punto valido di quel mondo religioso e culturale.
Secondo elemento: rintraccia quelli che possiamo considerare dei concetti comuni tra lui e i suoi interlocutori. Paolo ne individua tre: 1. L’esistenza di un principio creatore dell’universo e degli uomini (quello che Papa Francesco individua nella «fratellanza universale»); 2. Tutti gli uomini cercano la felicità, sono alla ricerca di senso; 3. Dio si fa prossimo ad ogni uomo.
Paolo, insomma, comincia con uno sguardo positivo sul mondo che pure all’inizio lo aveva disturbato.
Ma poi c’è un particolare interessante in questo discorso che potrebbe dire molto al nostro tempo e al compito che ci sta dinanzi, e che è nella metodologia prima ancora che nei contenuti. Ed è il fatto che Paolo non cita esplicitamente la Scrittura, ma semplicemente vi allude (v. 24). La ragione più probabile di tale modo di procedere deriva dal fatto che gli interlocutori di Paolo sono pagani e quindi ignorano la Scrittura. Ma anche perché per loro la Scrittura non è un testo autorevole. Sarebbe stato dunque inutile invocarla in appoggio al discorso che stava facendo. Paolo non cita la Scrittura, è vero, ma essa continua ad essere la sua fonte ispiratrice. Il fatto che non sia importante per loro non vuol dire che non lo sia anche per lui. Tutto il suo discorso, infatti, è intessuto della sapienza della Scrittura. Proprio perché resta il fondamento e l’ispirazione del suo pensiero, vive la fatica di tradurla nel linguaggio comprensibile a chi ha dinanzi. Non sbandierando citazioni, ma traducendo in parole comprensibili il valore umanizzante che hanno quelle parole. Questa è la grande sfida per noi, nella cultura del nostro tempo. Dove non ci viene chiesto di rinunciare a ciò in cui crediamo, ma di saperne trasmettere il valore benefico.
Fatemi concludere con una citazione ad effetto sui testimoni/martiri molto incisiva e bella.
È un passaggio di un’omelia di don Tonino, a conclusione della festa della Madonna dei martiri:
«Carissimi fedeli di Molfetta, c’è crisi di martiri. E non certo per difetto dei persecutori. Si direbbe che oggi nei grandi “magazzini” della fede cristiana puoi trovare di tutto: teologi, studiosi della religione, biblisti, operatori pastorali, predicatori, liturghi, tecnici della catechesi… ma se chiedi un martire, metti in crisi tutta l’azienda e obbligherai i proprietari a rovistare l’intero deposito per trovare qualche scampolo di questa “merce”, oggi decisamente fuori moda. […] Fedeli di Molfetta, nelle feste della Madonna dei martiri, imploriamo la Vergine santa affinché interpreti il ruolo di protettrice della nostra città come quello di una magazziniera che custodisce, intensifica, diffonde e rimette in circolo un genere di “prodotto” che, come nei primi tempi della Chiesa, fa dell’etichetta martirio la più splendida firma d’autore».