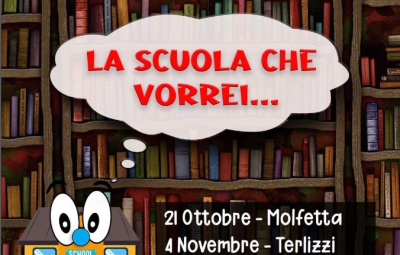di Don Tonino Bello
di Don Tonino Bello
Vescovo di Molfetta, Ruvo, Giovinazzo e Terlizzi
Carissimi,
il Natale ci chiama a rapporto ogni anno.
Provoca, cioè, così profondamente la coscienza a misurarsi con le forti idealità soggiacenti alla nostra vicenda umana, che è come se ci sentissimo citati in tribunale.
Un tribunale, però, che non incute paura.
Non tanto perché, invece che in un austero palazzo di giustizia, dobbiamo entrare in una grotta, dove, al posto della cattedra del magistrato, sovrasta una mangiatoia.
E neppure perché, invece che di fronte a un giudice dallo sguardo sospettoso, ci troviamo di fronte a un bambino inerme che, senza codici penali tra le mani, ci sorride e ci intenerisce. No!
È perché siamo certi che da questo tribunale non ce ne usciamo con le pesanti condanne che, a norma di tutti gli articoli della legge di Dio, pure meriteremmo per il nostro testardo e recidivo delinquere.
Anzi, ce ne veniamo fuori ogni volta interiormente rinnovati e con un fascio di speranze. La speranza che le cose possono ancora cambiare. Che sulla nostra irrecuperabilità non è detta l’ultima parola. Che la sentenza sulla nostra bancarotta spirituale non è passata ancora in giudicato. Che c’è chi continua a fare affidamento sulla nostra ripresa, e che, comunque, anche quando è costretto a pronunciarsi contro, ci sospende il rigore della pena con ripetute condizionali di favore.
La festa della nascita di Gesù diventa così per noi stimolo per la nostra rinascita.
E se per tutti, angariati come siamo dallo stress delle cose inutili, la povertà del Figlio di Dio si fa vortice di nostalgie e richiamo all’essenziale, per voi politici, in particolare, la culla di Betlem si trasforma in provocazione permanente a quei valori che hanno cullato gli esordi del vostro impegno sociale e che forse, inavvertitamente, avete smarrito per via.
Risuonerà, nella messa di mezzanotte, una splendida espressione di san Paolo, tratta dalla lettera a Tito, che dice così: “È apparsa la grazia di Dio, apportatrice di salvezza per tutti gli uomini, che ci insegna a rinnegare l’empietà e i desideri mondani e a vivere con sobrietà, giustizia e pietà in questo mondo, nell’attesa della beata speranza e della manifestazione della gloria del nostro grande Dio e salvatore Gesù Cristo”.
Vivere con sobrietà, giustizia e pietà. Mi sembra un forte articolato attorno a cui schematizzare la nostra revisione di vita.
Con Sobrietà.
Il termine “sobrietà” traduce una parola greca più complessa e più ricca, che corrisponde a: saggezza, equilibrio, padronanza di sé, moderazione, temperanza. Sobrio è colui che non è ebbro.
Sobrietà è l’opposto di ubriachezza.
Non è difficile, pertanto, intuire quale arcipelago di atteggiamenti morali viene evocato quando, parlando a uomini immersi nell’attività politica, li si esorta a vivere con sobrietà.
Non ubriacarsi di potere. Non esaltarsi per un successo. Non montarsi il capo con i fumi della gloria. Guardarsi dal capogiro dei soldi e della carriera. Coltivare religiosamente l’autocoscienza del limite. Evitare la sbornia delle promesse. Mantenere l’equilibrio nel vortice delle passioni.
Preservarsi dalle vertigini che può dare il potere d’acquisto della propria parola, sul tavolo delle spartizioni e dei compromessi.
C’è un passo biblico molto significativo, nel libro dei Proverbi, che vieta espressamente il vino a coloro che stanno a capo di un popolo: “Non conviene ai re bere il vino, né ai principi bramare bevande inebrianti, per paura che, bevendo, dimentichino i loro decreti e tradiscano il diritto di tutti gli afflitti” (Pr. 31,4).
Ovviamente, sotto la proibizione del vino materiale, si vogliono mettere in guardia gli uomini di governo da tutto ciò che, come si suol dire, può dare alla testa. Nessuno più di loro, infatti, è esposto alla tentazione dei “fumi” e al conseguente pericolo di provocare, con ubriacature morali, l’oblio delle leggi e il tradimento dei poveri.
Da queste considerazioni deve scattare per voi una sincera revisione critica dei vostri comportamenti pubblici, che vi porti a ripudiare ogni intemperanza di potere, ad aborrire dall’esercizio smodato dell’autorità, a convincervi umilmente che anche senza di voi il mondo riesce a sopravvivere e a ritrovare l’equilibrio nelle parole del Signore: “Quando avrete fatto tutto quello che vi stato ordinato, dite: siamo servi inutili. Abbiamo fatto quanto dovevamo fare” (Lc.17,10).
Se, però, l’invito alla sobrietà richiama in causa il comportamento dei singoli, non si esaurisce certo alla sfera personale, ma tocca anche un processo degenerativo comunitario, in atto nel sistema politico nazionale, che provoca riverberi funesti perfino nelle nostre città.
Ed è la partitocrazia, che potremmo chiamare l’ubriachezza dei partiti.
I partiti, secondo la carta costituzionale, dovrebbero essere i cosiddetti “corpi intermedi” la cui funzione è paragonabile a quella che il fusto svolge nella pianta. Il nostro modello di stato sociale, infatti, assomiglia proprio ad un albero le cui radici sono costituite dal popolo e i cui rami sono dati dalle pubbliche istituzioni.
Il compito del fusto, cioè dei partiti, è quello di raccogliere e coordinare le istanze vive della base per tradurle in domanda politica organica che vada a innervarsi sui rami.
I cittadini, quindi, sia singolarmente presi, sia associati in raggruppamenti primari detti “mondi vitali”, sono le radici del sistema in quanto detengono la sovranità e delegano il potere ai loro rappresentanti affinché lo esercitino nell’interesse del bene comune. I partiti, invece, hanno il compito di incanalare le spinte sociali diverse organizzando il consenso popolare attorno a una determinata politica.
La politica, perciò, secondo una splendida espressione dei vescovi francesi, può essere definita “coagulante sociale”, in quanto stringe forze diverse attorno ad un medesimo progetto.
È successo però, purtroppo, che il fusto è impazzito a danno delle radici e dei rami.
I partiti, cioè, si sono ubriacati.
Verso il basso, hanno espropriato i cittadini e i “mondi vitali” di alcune loro mansioni primarie, assorbendo per esempio l’informazione, l’editoria, la cultura, lo spettacolo, e spesso condizionando la vita di gruppi e associazioni.
Verso l’alto, hanno invaso quasi tutte le istituzioni dello stato, non solo lottizzandosi gli enti pubblici esclusivamente secondo criteri di appartenenza politica, ma anche mitizzando la disciplina di partito (se non addirittura di corrente) a scapito della coscienza individuale e snervando perfino la sovranità del Parlamento, sempre più ridotto a cassa di risonanza per accordi presi fuori di esso.
Non è più lo stato sociale, ma lo stato dei partiti.
Le conseguenze di questo corto circuito sono drammatiche.
Da una parte i problemi ristagnano, i progetti parcheggiano, gli intoppi burocratici si infittiscono, e perfino certe provvidenze di legge si incagliano sui fondali della sclerosi amministrativa, si usurano negli intrighi delle clientele, e naufragano nel gioco delle correnti.
Dall’altra parte cala la fiducia nella politica, visto che è stata ridotta dalla partitocrazia non a “coagulante” ma a “dissolvente” sociale. L’opinione pubblica accentua sempre più la tendenza ad angelicare la società e a demonizzare lo stato.
I giovani, pur sentendo una vivissima vocazione alla solidarietà, preferiscono riversare il loro impegno nel volontariato: questo sta a dire che rifiutano ormai le semplici proposte di gestione e cercano altrove i laboratori per la rigenerazione dell’humus etico della politica.
Si tirano indietro anche gli adulti, disgustati dallo spettacolo dei partiti che, abusando di reciproche interdizioni per osceni motivi di ingordigia nella spartizione delle pubbliche spoglie, producono, anche nelle nostre amministrazioni locali, paurosi ristagni e incredibili paralisi di governo.
Se è vero che l’impegno generoso e trasparente che si esprime in un partito, per il bene comune, è una forma altissima di carità, il fatto che le sezioni politiche si svuotino provoca nel vescovo una preoccupazione non meno sofferta di quando vede disertata la sede di un gruppo ecclesiale.
È urgente che i partiti, i quali restano pur sempre strumento essenziale della nostra democrazia rappresentativa, si disintossichino dall’ubriacatura.
Si ravvedano dal loro delirio di onnipotenza.
Riacquistino la sobrietà.
“Concorrano”, cioè, come dice l’art. 49 della Costituzione, “a determinare la politica nazionale”, ma senza la pretesa di monopolizzarla definitivamente. E tornino al loro compito fondamentale, che è quello di ascoltare la gente, educare i comportamenti, mediare gli interessi, e non certo di trasformarsi in forche caudine, da cui, anche per il più semplice sospiro, bisogna necessariamente passare, attraverso sistemi di tessere, clientele e patronati correntizi.
Con Sobrietà, ma anche con Giustizia, ci dice san Paolo.
Quando si parla di giustizia a uomini impegnati sul fronte politico, la tentazione più forte che bisogna ricacciare indietro è quella di evocare gli spettri inquietanti delle ambiguità amministrative, degli abusi settari, delle violenze gestionali a carico dei più deboli, dell’incredibile sonnolenza con cui vengono difesi i diritti dei poveri, del rapporto predatorio col denaro pubblico, della protervia con cui il potere viene usato a difesa dei privilegi di parte e non per la promozione del bene comune.
A dire il vero, non è che occorrano particolari capacità medianiche per far comparire questi spettri anche sui piccoli scenari dei nostri enti pubblici locali. Ma non gioverebbe a nulla. Farebbe solo gravare l’ombra del sospetto sulle tantissime persone pulite che pure vi operano: e sono forse la maggioranza. E accentuerebbe la diffidenza verso le istituzioni, favorendo quella pericolosa e inaccettabile divaricazione che oppone impegno sociale, ritenuto vergine e ingenuo, a impegno politico, ritenuto sordido e infido.
Oltretutto, non sarebbe neppure giusto che il vescovo, ergendosi a giudice freddo dall’alto delle sue sicurezze teologiche, rischiasse di fare una lettura approssimativa e semplificatoria di fenomeni complessi che, per essere ricondotti a trasparenza morale, richiedono, in chi li osserva, umiltà e pazienza più che declamazioni profetiche saccenti e disincarnate.
Smettendo allora di stendere lamenti, e volgendo in termini propositivi il richiamo di san Paolo, penso che non ci sia nulla di meglio che invitarvi a meditare su un passaggio fortissimo della Sollicitudo rei socialis. È il paragrafo 38, in cui il Papa, superando le antiche definizioni della giustizia intesa come virtù che spinge a dare a ciascuno il suo, adopera il termine più estensivo di “solidarietà”.
È una pagina splendida. Meriterebbe di essere ritagliata e custodita nel portafoglio. Non solo lo esorcizzerebbe dal pericolo di gonfiarsi di soldi a danno del prossimo, ma diverrebbe il più bel breviario del vostro impegno etico, volto alla promozione della giustizia e allo smantellamento di quelle strutture di peccato che, purtroppo, contano agenzie periferiche anche nelle nostre città.
Ecco che dice il Papa: “la solidarietà non è un sentimento di vaga compassione o di superficiale intenerimento per i mali di tante persone, vicine o lontane. Al contrario, è la determinazione ferma e perseverante di impegnarsi per il bene comune: ossia per il bene di tutti e di ciascuno, perché tutti siamo veramente responsabili di tutti. Tale determinazione è fondata sulla salda convinzione che le cause che frenano il pieno sviluppo siano la brama del profitto e la sete del potere. Questi atteggiamenti e strutture di peccato si vincono solo (presupposto l’aiuto della grazia divina) con un atteggiamento diametralmente opposto: l’impegno per il bene del prossimo con la disponibilità, in senso evangelico, a perdersi a favore dell’altro invece di sfruttarlo, e a servirlo invece di opprimerlo per il proprio tornaconto“.
Non potrebbe essere questa la griglia su cui innervare la revisione critica del vostro comportamento di uomini politici?
“Tutti siamo veramente responsabili di tutti“.
È più che una formula. È l’icona del bisogno struggente di cieli nuovi e di terra nuova, nascosto nel cuore di tutti.
Se si ammette che la solidarietà è l’imperativo etico fondamentale attorno a cui si deve innervare l’impegno dell’uomo, cade ogni legittimazione per moltissimi parametri di giudizio che finora facevano tranquillamente parte del nostro guardaroba spirituale.
Non si può più giudicare con sufficienza chi lotta contro la produzione delle armi, o contro il loro commercio, clandestino e palese. È vietato sorridere sugli slanci di chi parla di difesa popolare nonviolenta, o sostiene l’obiezione di coscienza. Non è ammissibile tacciare di follia chi teorizza la smilitarizzazione del territorio, o progetta modelli di sviluppo più legati alla vocazione dell’ambiente. Non va guardato con sospetto chi invoca leggi meno discriminatorie nei confronti dei terzomondiali, o si batte perché siano rispettati i diritti delle minoranze. Non va compatito chi disserta sulla remissione del debito dei paesi in via di sviluppo, o “farnetica” su un nuovo ordine economico internazionale.
L’etica della solidarietà, insomma, una volta introdotta nei nostri criteri di valutazione, obbliga partiti, sindacati e istituzioni allo smantellamento graduale di tutte quelle basi strategiche che finora hanno sorretto le antiche ideologie della sicurezza nazionale.
Anche se questa nuova coscienza planetaria, però, è una conversione indispensabile che ormai deve connotare lo stile dei raggruppamenti politici e delle istituzioni democratiche, non è il cambio più urgente che, a proposito di giustizia, ritengo debba avvenire nella gestione della cosa pubblica.
È, invece, un altro: il trasferimento nell’area obbligata dei diritti, e quindi anche dei doveri, di tutto ciò che spesso sembra lasciato alla zona incontrollata della vostra discrezionalità.
Continuare a mantenere larga questa zona significa perpetuare l’equivoco di un potere che crea dipendenze. Significa accarezzare manie pericolose di prestigio, se non proprio di dominio.
Significa coltivare sacrileghe mentalità da demiurghi. È come voler essere ago di una bilancia che, però, si fa di tutto perché rimanga falsa. Non tanto per rubare sul peso, quanto per dimostrare che la misura eccedente è frutto di magnanimità.
Io penso che oggi la truffa più grossa non si compie sottraendo, ma aggiungendo: aggiungendo apparentemente, è logico! In questo modo, è vero che si dà a ciascuno il suo, ma lo si dà facendo intendere che quel che gli si è dato non è tutto “suo”.
È questa un’operazione diabolica, soprattutto perché coperta dall’alibi morale che, in fondo, non si è sottratto nulla, non ci si è arricchiti a danno del prossimo, né si sono create ingiustizie sostanziali. A ben pensarci, però, si è rubata una gratitudine indebita che alla lunga potrà anche fruttare. Ci si è arricchiti di un potere d’acquisto sul mercato del consenso. E si è creato quel vassallaggio clientelare che è il vero bubbone maligno delle nostre strutture.
Attenzione, amici. Aggiustate le bilance! Perché non si ruba solo quando si ricava profitto sulla merce. Si ruba anche quando si ricava potere sulle coscienze.
Con Sobrietà, con Giustizia e con Pietà, dice san Paolo.
Nel nostro linguaggio moderno, pietà è lo scrupoloso esercizio dei doveri religiosi.
Una persona si dice pia quando è fedele al Signore e osserva la sua legge.
Nella Bibbia, però, la pietà ha una estensione maggiore, perché implica anche le relazioni dell’uomo con gli altri uomini, e sembra particolarmente compromessa non solo quando si reca oltraggio a Dio, ma anche quando i poveri vengono calpestati.
In altri termini, pietà è l’atteggiamento di chi vuole così bene a Dio, che sente il bisogno di prolungare questa benevolenza rapportandosi con i fratelli.
Come empietà, che è il contrario, indica non solo il disprezzo di Dio, ma anche ogni forma di ferocia, di scelleratezza e di crudeltà nei confronti del prossimo. Non per nulla l’aggettivo empio lo si abbina spesso al sostantivo tiranno.
Bene: a che cosa san Paolo vuole in particolare richiamare voi, uomini impegnati nell’attività politica, quando esorta tutti a vivere, oltre che con sobrietà e giustizia, anche con pietà?
Anzitutto a un quadro di valori che trascenda le categorie dell’immediato, dell’effimero, del fruibile in termini di contingenza.
Oggi si sente parlare sempre più spesso di rapporto tra etica e politica.
Nelle conversazioni ritorna di frequente il tema della cosiddetta questione morale.
Si moltiplicano le tavole rotonde sul problema dell’ancoraggio della prassi politica al molo di un “assoluto” cui riferirsi come a orizzonte globale indipendentemente dalle convinzioni religiose personali.
Che cosa è tutto questo, cari amici, se non una sollecitazione a coltivare con rinnovato entusiasmo, a dispetto della nequizia dei tempi, le calde utopie, le passioni ideali e i sogni diurni oggi particolarmente in ribasso? In secondo luogo oltre che richiamarvi al “quadro” di valori, chi sa che san Paolo non voglia anche farvi pensare al “chiodo” a cui il quadro è attaccato?
Chi sa che il problema di Dio, da alcuni forse accantonato, o messo tra parentesi, o negativamente risolto, non si riproponga in questo Natale con tutta la sua cogenza spirituale che vi sottragga dall’inquietudine, vi riscatti dall’inappagamento e vi ricolmi di pace interiore?
Se è vero, però che la pietà è in primo luogo l’atteggiamento che regola il rapporto dell’uomo con Dio, non si può dimenticare che questo Dio sta sempre dalla parte degli oppressi e ritiene fatto a sé ogni gesto di misericordia riservato ai suoi poveri.
Sicché, per voi politici vivere con pietà deve significare soprattutto onorare l’uomo come icona di Dio.
Un invito pressante vorrei rivolgervi, perciò, carissimi amici, in questo momento.
Privilegiate l’uomo, più che la pietra.
Capisco che costruire un asilo, innalzare una scuola, sistemare una piazza, ampliare un porto, edificare un mercato, sottoscrivere un progetto di espansione urbanistica gratifica di più che disegnare scientificamente la mappa cittadina del disagio o impostare con rigore tecnico il centro di animazione sociale del quartiere, o provvedere al servizio domiciliare degli anziani, o istituire strutture per l’accoglienza di minori in difficoltà, o allestire speciali programmi riabilitativi per i portatori di handicap, o predisporre forme di accoglienza perché i dimessi dal carcere o dagli ospedali psichiatrici non vadano allo sbando, o potenziare i servizi sociali perché raggiungano in modo organico, dignitoso e tempestivo, coloro che vivono ad alto rischio di emarginazione.
Sì, perché la pietra lascia incisa la firma per i secoli futuri. Il cuore dell’uomo, invece, sopporta l’autografo soltanto il tempo necessario per dire “grazie”.
Ma ricostruire l’uomo vale infinitamente di più che costruirgli la casa.
Adoperatevi, vi supplico, perché migliori la qualità della vita nelle nostre città.
Mettete più spirito di sacrificio per arginare i guasti di tanta disoccupazione giovanile: non con palliativi demagogici e superficiali, ma con investimenti seri di tempo più che di soldi, di cervello più che di espedienti, di passione più che di calcolo.
Aprite gli occhi sul degrado umano procurato dalla droga, dalla delinquenza minorile, dai cento fenomeni di malcostume che indicano un forte abbassamento di orizzonti etici. La siringa trovata in villa deve fare impallidire la giunta comunale più dei liquami di una fognatura, fuoriusciti in piazza durante una cerimonia ufficiale.
Impegnatevi perché ogni scelta politica tenga sempre presente gli ultimi.
Misuratevi più decisamente con le povertà, aborrendo dal gestirne i bisogni con atti occasionali, e favorendo, invece, quei piani complessivi di intervento per i quali sono predisposte anche delle provvidenze di legge, ma che la pigrizia o la leggerezza o l’incompetenza lasciano scandalosamente inutilizzate.
Vigilate affinché i processi di crescente disuguaglianza tra cittadini, o gruppi, o categorie sociali, non finiscano col favorire sempre chi è in grado di organizzare meglio la domanda trasformando così lo stato in commesso degli interessi dei più forti.
Se questa “pietà” per l’uomo vi farà anteporre alle pietre i problemi pubblici della salute, dell’educazione, della cultura, del lavoro, del rispetto per l’ambiente, della partecipazione…Gesù Cristo, che ha promesso il Regno a chi avrà dato un solo bicchiere d’acqua fresca per amore, non sarà avaro neppure con chi è convinto di non averlo mai incontrato su questa terra.
Non vi scoraggiate, amici. Chiedete al Cielo il dono di una genialità nuova che vi metta in grado di esprimere, su scenari politici più giusti, il vissuto e le ansie dell’uomo contemporaneo, alle soglie del terzo millennio.
E non lasciatevi cadere le braccia quando, nonostante il vostro impegno personale improntato a trasparenza e rettitudine, vi vedete destinatari di sospetti da parte di chi, non comprendendo la vostra fatica, spara nel mucchio con raffiche ingenerose di luoghi comuni.
Non demordete: la coerenza paga, anche se con qualche ritardo. Paga anche l’onesta. E la speranza non delude!
Tanti auguri, carissimi amici.
Siate portatori della pubblica gratitudine presso le vostre famiglie, costrette spesso, per il bene di tutti, a rinunciare alla vostra presenza in casa.
Possiate trovare nel vostro duro lavoro il sostegno dei cittadini, la solidarietà dei collaboratori, il rispetto degli avversari, il consenso degli ultimi, la benedizione di Dio.
La Vergine Maria vi preservi dal pianto.
Ma vi conceda il privilegio di intenerirvi davanti alle sofferenze dei poveri.
Fino alle lacrime.
Buon Natale.
Il messaggio augurale di Don Tonino è stato pubblicato dalla Casa Editrice “La Meridiana” di Molfetta nel libro “Mistica Arte – lettere sulla politica” (anno 2005) che contiene anche il CD del testo registrato.
+ Antonio Bello